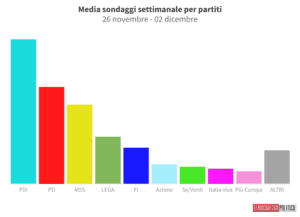Senza categoria
La politica americana ha chiesto a Cuomo di dimettersi, ma lui non l’ha ancora fatto
Il governatore di New York Andrew Cuomo ha ricevuto diversi appelli a dimettersi dopo il rapporto conclusivo dell’Ufficio […]
I risultati delle Primarie nell’11° e nel 15° distretto congressuale dell’Ohio
Per il Partito Democratico è stata una sfida combattuta fino all’ultimo, nel Partito Repubblicano ha pesato molto l’endorsement […]
In Ohio ci sono due elezioni speciali da tenere d’occhio
Si tratta dell’undicesimo e del quindicesimo distretto dell’Ohio: nel primo il Deputato che lo aveva vinto ha dovuto […]
Negli Stati Uniti il diritto di voto è una questione di partigianeria
Un nuovo sondaggio del Pew Research Center in America mostra la divisione fra democratici e repubblicani sul diritto […]
Biden ha lo stesso indice di gradimento da sei mesi
La cosa può essere vista come un problema ma anche come un’opportunità. Rispetto a quello degli ultimi Presidenti, […]
La campagna elettorale per il Senato statunitense costa
Dopo la conclusione della lunghissima campagna Usa2020 – terminata con la vittoria dem nei ballottaggi in Georgia – […]
Le reazioni politiche all’apertura della crisi di Governo
Un grave errore fatto da pochi che pagheremo tutti. — Andrea Orlando (@AndreaOrlandosp) January 13, 2021 […]
La reazione austriaca al terrorismo di matrice religiosa
Mercoledì 16 dicembre, il Governo austriaco ha presentato le prime misure del nuovo Anti-Terror Paket. Questo pacchetto, fortemente […]
Quale futuro per le Big Tech americane?
È di pochi giorni fa la notizia che ha visto il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti d’America […]
Oslo si batte per la tutela dei valori europei
L’UE temporeggia e non prende provvedimenti verso alcune decisioni politiche controverse adottate da paesi come Polonia e Ungheria. Dall’alto […]
Programmi elettorali Puglia
PROGRAMMI COMPLETI Michele Emiliano Raffaele Fitto Antonella Laricchia Ivan Scalfarotto Nicola Cesaria Mario Conca Pierfranco Bruni Andrea D’Agosto